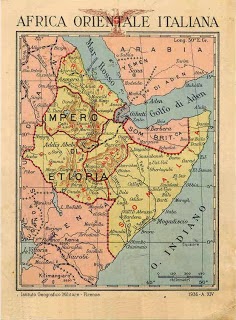GLI ECCIDI DI SPALATO E MARIA PASQUINELLI (di Giovanni Miccolis)
I partigiani di Tito s’impossessarono della città di Spalato in Dalmazia dal 10 al 27 settembre 1943, giorno di arrivo dei tedeschi. Tutto l’apparato statale italiano del "Governatorato di Dalmazia", così efficiente fino all’armistizio, si frantumò trasformando militari, funzionari e civili in una massa di sbandati senza protezione e senza diritti, alla mercè di criminali che non rispettavano alcuna norma del diritto internazionale, dei principi cristiani, del vivere civile.
Così, in quei pochi giorni persero la vita circa settecento italiani, civili e militari, trucidati senza pietà dai partigiani di Tito.
A Spalato esistevano, prima dell’invasione, molti italiani (circa 2000) e ad essi si aggiunsero nel 1941, con l’assegnazione all’Italia, molti esuli spalatini, nonché centinaia di funzionari e insegnanti
provenienti da altre province italiane. Furono riaperte le scuole italiane, accanto alle scuole croate.
I partigiani di Tito si dimostrarono tolleranti con i normali militari, ma furono spietati con le
camicie nere ed “i servitori” del regime fascista (carabinieri, guardie di finanza, funzionari di
pubblica sicurezza, funzionari statali e insegnanti).
Furono così trucidati 10 carabinieri, 11 guardie di finanza, 41 poliziotti di P.S. e circa 250 civili i
cui corpi finirono in tre fosse comuni nei pressi del cimitero di San Lorenzo e della Baia dei
Castelli.
Il Questore di Spalato era riuscito a fuggire ed a dirigere la città erano rimasti soltanto quattro
funzionari di polizia: il commissario Francesco Metano, il vice-questore Paride Castellini, gli
ufficiali Papoff e Sorgi, nonché gli agenti della Questura, tutti in soccorso degli oltre 1.500 italiani di
Spalato. Francesco Metano, catturato dai partigiani, fu fucilato il 19 settembre nei pressi del
cimitero di San Lorenzo. Intanto, gli edifici pubblici - Comune, Prefettura, Questura – furono dati
alle fiamme.
Anche il Comando della Marina era sguarnito per la fuga dei comandanti. Gli agenti fuggiaschi
cercarono scampo nelle campagne e quelli catturati furono fucilati sul posto e lasciati a marcire.
Tra le persone trucidate vi erano tanti insegnanti, tra i quali:
Scordiglio Maria, da San Caio (Spalato), insegnante elementare;
Menenghin Cesare, da Spalato, ivi insegnante alle elementari;
Luginbuhl Eros, da Ferrara, già preside del Ginnasio "G.R. Carli" di Pisino, poi del Ginnasio di
Spalato; arrestato dagli slavi il 21-9-1943 a Spalato, fu marchiato con una stella di fuoco sulla
fronte e fucilato il giorno seguente;
Soglian prof. Giovanni, nato il 3 marzo 1901 a Cittavecchia (Lesina- Hvar), provveditore agli Studi
di Spalato; rifiutò di salvarsi per poter assistere tutti gli insegnanti in pericolo; arrestato, venne
fucilato il 23 settembre, dopo che sul petto gli era stata impressa a fuoco una stella.
Il 30 agosto, e cioè poche settimane prima di essere incarcerato e fucilato, Giovanni Soglian, chiese
al Governo di Roma opportune disposizioni per salvare dai partigiani gli insegnanti italiani della
provincia. Nell’angoscia e nel pericolo assicurò il normale svolgimento della sessione degli esami
autunnali, fiero della sua italianità:
«Mi sia lecito premettere che nessuno più di me, che per
l'italianità della Dalmazia ho lottato e duramente sofferto in un quarto di secolo ormai, desidera e
spera che nonostante tutto questa terra rimanga congiunta alla Madre Patria. E mi sia consentito
anche dichiarare che a tal fine sono pronto ad affrontare qualunque sacrificio, come da due anni
affronto a Spalato ogni rischio personale. Questo desiderio e questa speranza però non debbono
impedirmi e non mi impediscono di giudicare le cose con quel senso della realtà che nelle
condizioni attuali nella provincia di Spalato è necessaria e doverosa per evitare errori e decisioni
comunque contrari agli interessi nazionali»
.
Da giorni i partigiani erano in giro a catturare nemici da ammazzare, ma Soglian rimase al suo posto
facilitando la fuga soltanto dei suoi collaboratori. Avrebbe potuto facilmente nascondersi in una
città che conosceva molto bene, ma aspettò sereno i suoi carnefici che lo presero il 21 settembre. Fu
portato nelle carceri di S. Rocco in Riva e, dopo due giorni, gli fu impressa a fuoco sul petto una
stella, fu fucilato e buttato con gli altri nella fossa che le stesse vittime avevano scavato.
Maria Pasquinelli
Sua segretaria degli ultimi giorni era la trentenne insegnante Maria Pasquinelli, sconvolta per gli
orrendi crimini, ma capace di mostrare imperturbabilità esterna. Fu arrestata insieme agli altri
docenti che non subirono il martirio, abbandonata in una cella senza viveri. Furono le altre
prigioniere, le donne croate a sfamarla in quei giorni di dolore. Seguirono angherie e violenze
emerse dalla relazione della stessa.
Quando a Spalato arrivarono i tedeschi e fu liberata, la Pasquinelli si recò immediatamente dal Comando di Piazza per il permesso di disseppellire le vittime dei partigiani e, facendosi accompagnare dal prof. Camillo Cristofolini, esplorò le tre fosse comuni ricolme di puzzolenti cadaveri.
Maria aveva accompagnata da ragazza suo padre, incaricato di portare i resti mortali dei caduti della Prima Guerra Mondiale a Redipuglia, e non aveva timore del contatto con le salme.
Ritenevano di trovare un centinaio di morti, in base alle notizie raccolte presso il comando militare,
ma vi era il doppio dei cadaveri previsti.
Eseguita la macabra missione ebbero la fortuna di imbarcarsi sul piroscafo “G. Mameli” diretto a
Pola ed a Trieste.
Era il 27 ottobre e la nave lungo il tragitto fu bombardata dai tedeschi. Vi furono tanti morti e perì
anche il prof. Cristofolini. Il piroscafo, dopo un anno circa, fu affondato nei pressi di Muggia il 14
novembre 1944.
A Trieste, fu richiesta a Maria una relazione sui fatti di Spalato, con particolare riferimento alla
scuola. Una relazione di estremo interesse della quale si ripropone un sunto degli aspetti più
interessanti:
-Il giorno dopo l’annuncio dell’armistizio, alle ore 19, i partigiani tennero una manifestazione sulla
Riva alla quale parteciparono i nostri militari. Sui mezzi italiani salirono ragazzi e ragazze con
stracci rossi che infilarono anche nelle giubbe dei soldati. Seguì l’ammaina bandiera del vessillo
italiano con l’alza bandiera rossa dei comunisti e dello stendardo inglese.
-Il 10 il provveditore Soglian fece bruciare gli archivi segreti, dispose per la consegna alla Banca
d’Italia dei mandati di pagamento degli stipendi e invitò i docenti a tenersi pronti per l’eventuale
partenza. Alle ore 19 si formò una coda urlante di insegnanti all’ingresso della Banca d’Italia che
aveva interrotto le operazioni dopo i primi pagamenti. Sul porto si affrettarono in molti con i
bagagli, ma fu loro imposto di allontanarsi. A mezzanotte si seppe che l’ammiraglio Bobbiese, il
figlio ed alcuni ufficiali superiori erano partiti con la nave “Illiria” praticamente vuota [Bobbiese
era il comandante di “Maridalmazia”].
-Il giorno 11, sabato, i docenti ritornarono a fare la coda davanti alla Banca d’Italia, ma cominciò un
bombardamento che danneggiò proprio i due piroscafi destinati a portare via il personale della
scuola. La Banca chiuse e fu costretta a consegnare 15 milioni, esistenti in cassa, ai partigiani. Nel
pomeriggio gli ufficiali ed i soldati italiani erano circondati da ragazzacci e donnacce che
toglievano loro fucili, pistole, cinturoni e, talvolta, anche la divisa. La città era nel caos e sul porto
furono rubati i bagagli degli italiani in partenza. Gli insegnati si rifugiarono nella sede della Lega
Culturale Italiana. Nella notte bruciavano la Questura ed il Comune. Per la strada passavano
partigiani carichi di ciò che avevano sottratto nelle case degli italiani e nei negozi.
-Il giorno 12 un ufficiale della Caserma Roma si rese disponibile per la difesa della scuola dove
erano affluiti tanti italiani desiderosi anch’essi di lasciare Spalato.
-La mattina seguente alcuni partigiani perquisirono i rifugiati della scuola e li derubarono. Le strade
si riempirono di manifesti inneggianti al comunismo ed a Stalin. Non v’era più traccia dei circa
18.000 soldati italiani: molti avevano ceduto le armi ai partigiani rifugiandosi sul monte Mariano; il
colonnello Venerandi con i suoi carabinieri si era unito ai partigiani contro i tedeschi; le caserme
erano abbandonate ed i 1.500 civili italiani erano alla mercè dei partigiani.
-La sera del 13 Maria fu prelevata d un partigiano per essere violentata. La ragazza ebbe una
reazione violenta, tanto da provocare l’intervento altri due partigiani e nella confusione la donna
riuscì a svincolarsi ed a rifugiarsi tra le colleghe.
-Il mattino successivo Maria si allontanò dai compagni ben sapendo che i partigiani l’avrebbero
cercata. Infatti, dopo qualche ora alcuni brutti ceffi rovistarono in ogni angolo e, non avendo trovato
la preda, arrestarono il prof. Cristofolini e lo portarono nel carcere di San Rocco.
Soglian, per evitare altri arresti, fece allontanare i presidi Luginbuhl, Fiameni e Caretto, nonché il
prof. Posar, invitandoli a raggiungere il monte Mariano per trovar rifugio tra i nostri militari. Il
cappellano, ten. Amantini, presentò al gen. Cigala Fulgosi i presidi Luginbuhl e Caretto, pregandolo
di tenerli nascosti fino ad una eventuale partenza, così come facevano di notte tanti soldati. Il
generale rifiutò. Gli altri docenti preferirono avvicinarsi di nascosto e riuscirono a confondersi con i
militari.
Intanto il preside Soglian pregò il parroco della chiesa di Santo Spirito, don Merlo, di intercedere
presso il Vescovo, affinchè facilitasse la partenza almeno di donne (minacciate di violenze) e
bambini. Tutto il personale della scuola si trasferì nella chiesa di Santo Spirito in attesa degli eventi.
-Il 15 Maria riuscì a raggiungere la sua padrona di casa e la trovò sconvolta, perché alcuni
partigiani, intenzionati a catturarla, le avevano chiesto una sua fotografia. La donna si prestò per
darle rifugio presso una sorella, ma Pasquinelli preferì tornare dai colleghi affrontando l’incerto
destino.
-Il 16 la sua padrona di casa entrò sconvolta nella chiesa e riferì che erano tornati da lei i partigiani,
infuriati della mancata cattura della donna che li aveva umiliati. La presenza di Maria in chiesa era
ormai nota ai titini, seguì l’arresto, il trasferimento nel carcere di San Rocco e l’interrogatorio, nel
corso del quale, non negò di essere stata fascista con grande sorpresa degli aguzzini.
-Arrivò il 18 settembre. In cella non riusciva a dormire per le cimici. Sentì condurre fuori dalle
stanze un certo numero di prigionieri che furono portati sui camion, per un viaggio senza ritorno.
- Il 19 fu liberata e fece ritorno a Santo Spirito dove trovò che qualcuno si faceva convincere dalla
propaganda comunista e non credeva che in quei giorni si commettevano crimini di ogni genere.
-Il 21 Luginbuhl fu prelevato da tre partigiani e condotto a San Rocco, nella cella dei condannati a
morte. Con altri sette fu fatto allontanare in un lugubre silenzio. Maria seppe da un capitano cosa
accadeva a coloro che venivano portati via: i condannati scavavano una buca e vi si stendevano
dentro affiancati; i titini sparavano quindi alla testa dei malcapitati.
-Il martedì 21 Maria pregò Soglian di nascondersi (aveva tanti amici in città), ma ebbe un netto
rifiuto ed una risposta serena:
“Ho fatto molto bene ai Croati, ne avrò salvati almeno trecento. Se
volessero essere giusti dovrebbero darmi una benemerenza. Se poi saranno ingiusti…mi metterò
nelle mani di Dio”.
Si mise al lavoro fino a che due partigiani entrarono per portarlo via.
-Il 22 il pasto mandato a Luginbuhl fu rimandato indietro con la risposta:
“E’ stato trasferito”.
-Il 24 si videro respingere il pasto destinato a Soglian.
-Il 25 si udirono fragorosi scoppi e qualcuno disse che arrivavano i tedeschi. I partigiani minarono il
porto, la stazione e le carceri e, subito dopo, si allontanarono.
-Il sabato e la domenica passarono tra urla della gente dedita al saccheggio delle case.
-Il 27 presero possesso della città i tedeschi e misero al potere gli ustascia.
-Il 3 ottobre Maria si recò con l’amica prof.ssa Ledvinka al cimitero per notizie sulle fucilazioni.
Apprese che esistevano tre fosse comuni per i fucilati dal 18 al 24 settembre e fece richiesta alle
Autorità di disseppellire i cadaveri per il riconoscimento. Ma gli ustascia si interessarono soltanto
della prima fossa dove erano alcuni della loro gente.
-Il 9 Maria si fece accompagnare al cimitero dal prof. Cristofolini. Notarono tre fosse in
continuazione per una lunghezza di trenta metri circa. Le autorità si opposero alla rimozione dei
corpi della seconda e della terza fossa e si limitarono ad assistere al trasferimento dei corpi della
prima. Vi erano 29 cadaveri privati dei documenti e degli oggetti personali. Per l’esumazione dei
corpi nelle altre due fosse le Autorità chiesero la somma di L. 24.000. Non era possibile reperire la
somma richiesta tra persone ormai derubate e quel poco che avevano era insufficiente persino a
sfamarsi.
Maria non si diede per vinta ed arrivò ad un maggiore dei tedeschi, riconoscente verso gli italiani
del locale ospedale dove erano stati curati due connazionali. Finalmente giunse l’autorizzazione e
dal 20 al 22 si procedette all’esumazione dei cadaveri. Con il prof. Cristofolini esaminò 105
cadaveri ormai putrefatti difficilmente riconoscibili. Quando dai vestiti e dalle fattezze dei corpi
individuarono Soglian e Luginbuhl li misero in due casse per una più degna sepoltura. Anche i
familiari dei fucilati cercarono i loro cari per una privata sepoltura. Gli altri corpi furono rimessi
sotto terra.
Per la sepoltura era necessario l’intervento dell’Ufficiale Sanitario che pretese una forte tassa. Maria
non si presentò e non seppe in seguito se a quelle tombe fu data una identificazione civile.
Maria fu avvertita che era in pericolo e per sua fortuna nel porto comparvero due navi mercantili, la
“Marco” e la “Goffredo Mameli”, che dovevano sbarcare dei feriti provenienti dall’Albania e
ripartire. I due salirono di nascosto sulla “G. Mameli” e poco dopo fu autorizzato il trasporto di un
centinaio di civili.
All’altezza dell’isola di Zirona vi fu un bombardamento dei partigiani. La “Marco”, colpita ai
motori, fece ritorno a Spalato. Sulla “G. Mameli” si ebbero tanti morti ed uno di questi era
Cristofolini.
Maria tornò a Pola e poi a Trieste col ricordo dei tanti morti. Quanti? Non si saprà mai il numero
preciso degli omicidi commessi dai partigiani in quei giorni. Sulle persone uccise si raccolsero
testimonianze, talvolta contrastanti. Così, il capo gabinetto del Prefetto di Spalato, dottor Scrivano,
riferì di aver visto prelevare, di notte dal carcere dove era detenuto, non meno di duecentocinquanta
persone. Da altra indagine, svolta dopo la guerra, furono individuati nella zona di Spalato-Traù 53
civili e 43 guardie di pubblica sicurezza uccisi dai partigiani. Da tener conto, però, che, anche prima
dell’ 8 settembre, la pubblica sicurezza aveva avuto 6 morti, i carabinieri 10, e la guardia di finanza
15. Nelle altre località della Dalmazia, al di fuori di Zara, Spalato e Traù, furono identificati 44
civili, 18 guardie di pubblica sicurezza, 16 guardie di finanza e 30 carabinieri uccisi dai titini.
Maria Pasquinelli rimase scossa da quell’esperienza e meditò a lungo un gesto folle.
Il Processo di Maria Pasquinelli
Maria Pasquinelli divenne internazionalmente nota per quanto fece nel 1947 a Pola, diventando col suo gesto (l'uccisione del generale britannico De Winton) l'eroina dei profughi istriani-fiumani-dalmati.
All’anagrafe risulta Maria Anna Luisa Pasquinelli, nata a Firenze il 16 marzo 1913, da madre
bergamasca e padre jesino. Si laureò giovanissima in Pedagogia ad Urbino e fu iscritta al Partito
Fascista dal 1933 al 25 luglio 1943. Allo scoppio della guerra partì volontaria come crocerossina in
Cirenaica ed alla vista delle sofferenze dei soldati si tagliò i capelli e si travestì per combattere
unitamente agli uomini, ma poco dopo fu scoperta ed espulsa dalla Croce Rossa per indisciplina.
Nel 1942 fece domanda di insegnamento in Dalmazia, laddove la comunità italiana era sotto
minaccia dei partigiani.
Rientrata a Trieste, fu molto attiva nel denunciare la situazione delle popolazioni slave e si inimicò
anche i tedeschi che l’arrestarono minacciando la deportazione. In suo favore intervenne Junio
Valerio Borghese, anch’egli interessato all’italianità dei territori slavi.
Era finita la guerra, ma la situazione delle popolazioni confinarie con la Jugloslavia non migliorò.
Ed ecco che il 10 febbraio 1947 avvenne a Pola il fattaccio. Era previsto il passaggio dei poteri
dagli Alleati agli slavi titini ed il brigadiere generale inglese Robert W. De Winton passava in
rassegna i militari della guarnigione schierati davanti alla sede del Comando.
All’improvviso si staccò dalla folla una donna, si avvicinò al generale, estrasse una pistola dalla borsetta e sparò quattro colpi uccidendolo. Quella donna era Maria Pasquinelli che non scappò, ma si consegnò ai militari dando loro un biglietto nel quale era spiegato il gesto. In precedenza aveva consegnato ad un amico due lettere che dovevano essere spedite, una ai “Volontari Istriani”, l’altra al “Gruppo Esuli Istriani”.
Nel biglietto era scritto:
« Seguendo l’esempio dei 600.000 Caduti nella guerra di redenzione 1915-18, sensibili come siamo
all’appello di Oberdan, cui si aggiungono le invocazioni strazianti di migliaia di Giuliani infoibati
dagli Jugoslavi, dal settembre 1943 a tutt’oggi, solo perché rei d’italianità, a Pola irrorata dal
sangue di Sauro, capitale dell’Istria martire, riconfermo l’indissolubilità del vincolo che lega la
Madre-Patria alle italianissime terre di Zara, di Fiume, della Venezia Giulia, eroici nostri baluardi
contro il panslavismo minacciante tutta la civiltà occidentale. Mi ribello con il proposito fermo di
colpire a morte chi ha la sventura di rappresentarli - ai Quattro Grandi, i quali, alla Conferenza di
Parigi, in oltraggio ai sensi di giustizia, di umanità e di saggezza politica, hanno deciso di
strappare una volta ancora dal grembo materno le terre più sacre all’Italia, condannandole o agli
esperimenti di una novella Danzica o - con la più fredda consapevolezza, che è correità - al giogo
jugoslavo, oggi sinonimo per le nostre genti, indomabilmente italiane, di morte in foiba, di
deportazione, di esilio ».
Il riferimento nel biglietto a Guglielmo Oberdan non era casuale: nei pressi del Tribunale l’eroe
dell’irredentismo italiano fu impiccato il 20 dicembre 1882 e Maria si batteva per gli stessi ideali.
Quel gesto suscitò infinite discussioni sulle vere motivazioni, ma a capirle veramente forse fu
proprio l’inviato dell’Associated Press, Michael Goldsmith, che scrisse:
«Molti sono i colpevoli, i polesani italiani non trovano nessuno che comprenda i loro sentimenti. Il
governo di Roma è assente, gli slavi sono apertamente nemici in attesa di entrare in città per
occupare le loro case, gli Alleati freddi ed estremamente guardinghi. A questi, specie agli inglesi,
gli abitanti di Pola imputano di non avere mantenuto le promesse, di averli abbandonati».
Dopo due mesi si svolse il processo davanti alla Corte Militare Alleata di Trieste e Maria si dichiarò
colpevole, ma spiegò che non intendeva colpire l’uomo, bensì ciò che rappresentava: gli Alleati che
stavano firmando il Trattato di Pace che mutilava l’Italia.
L’avvocato difensore, Luigi Giannini, era perplesso sulla linea difensiva e, conoscendo la sua
profonda fede religiosa, un giorno le chiese come aveva potuto decidersi a quell’estremo gesto. La
sua fu una risposta terribile:
“Forse ho amata l’Italia anche più della mia anima”.
Il dieci aprile la Corte emise la sentenza che era la condanna a morte. Maria, invitata a parlare,
disse:
«Ringrazio la Corte per le cortesie usatemi; ma sin da ora dichiaro che mai firmerò la
domanda di grazia agli oppressori della mia terra».
L’orgogliosa donna fu rinchiusa nel carcere di Perugia, quindi in quello di Venezia ed ancora nel
penitenziario di Firenze. Nel 1954 la pena capitale fu commutata in ergastolo e, per effetto delle
amnistie, fu liberata il 22 settembre 1964.
Da quel momento vive in orgogliosa solitudine, rifiutando interviste. Le sue uniche parole furono
una volta:
“Sono nata a Firenze con altri due miei fratelli, in via delle Panche. Mia madre era bergamasca e
di questa gente io ho la spregiudicata schiettezza. Mio padre invece era marchigiano, di Jesi”.
Di tutto il resto silenzio, a coprire vicende che provocano soltanto amarezza e sofferenza.
Soltanto tre anni fa ha accettato di incontrare nella sua casa di Bergamo la giornalista Rosanna
Turcinovich Giuricin per alcuni colloqui. La giornalista ne ha tratto un libro: “
La giustizia secondo Maria. Pola 1947: la donna che sparò al generale brigadiere Robert W. De Winton”
– Del Bianco Editore, 2008.
Al momento dell'intervista ha 97 anni; Maria non parla molto con la giornalista, ma dai colloqui e dalle testimonianze dell’amica del cuore di Maria, Giuditta Perini, vengono fuori alcuni segreti custoditi da oltre sessant’anni.
Si ipotizza,così, che la pistola sia stata data da un certo Giuliano che all’ultimo momento non ebbe il coraggio di sparare. Si racconta dell’amicizia in carcere con un’ergastolana famosa “la belva di San
Gregorio” che uccise la moglie del suo amante ed i tre figli piccoli. Si accenna alla lettera che Maria
scrisse alla moglie di De Winton, nonché alla visita in carcere del fratello del generale ucciso.
L’autrice si sofferma sulle attività di assistenza spirituale del vescovo di Trieste, monsignor Antonio
Santin, che ha sempre descritto Maria come una donna “di alta spiritualità”. La Pasquinelli rifiutò
più volte di chiedere la scarcerazione, ma nel 1964 sua sorella aveva gran bisogno di assistenza e
finalmente accettò la libertà per trasferirsi a Bergamo.
Al termine del libro la giornalista riferisce con commozione:
«Maria Pasquinelli mi ha sempre detto che il suo morto se lo porta dietro le spalle, il suo fiato lo sente sul collo e il tempo non riuscirà a cambiare nulla della tragedia che è stata».
I suoi furono gli ultimi spari della seconda guerra mondiale. Ed il gesto si caricò subito di tutta una serie di significati per i trecentocinquantamila profughi italiani della diaspora istrianofiumanodalmata, che fecero di lei un'eroina ancora oggi ricordata.
Maria Pasquinelli muore a 100 anni a Bergamo nel luglio 2013, ricordata da molti italiani (e finanche dalla stampa anglosassone). Al suo funerale il
Libero comune di Pola in esilio la ha onorata definendola il "fiore d'Italia" ai tempi dell'esodo istriano.